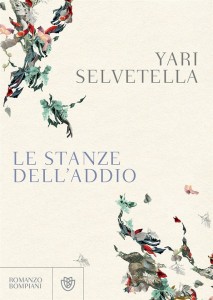 Ho scritto due recensioni del capolavoro di Yari Selvetella. Un libro che sareste veramente pazzi a non leggere immediatamente. Una è dedicata esclusivamente al suo romanzo, ed è pubblicata su La poesia e lo spirito, e un'altra – per Le donne visibili – che contiene anche una parte dedicata alla letterata Giovanna De Angelis, mancata esattamente cinque anni fa oggi. Giovanna è molto ingiustamente sconosciuta ai più. In un altro Paese non sarebbe mai passata altrettanto inosservata al di fuori degli addetti ai lavori. Fa tutto parte di uno schema di cultura patriarcale in cui siamo imbibiti. Ma la sua mancanza è dolorosissima e la sua voce sarebbe stata enormemente necessaria in questo momento storico in cui il #metoo italiano è così vittima di vent'anni di berlusconismo dilagante e permeante. Sono felice che ci sia il suo romanzo da leggere, e ora anche quello di uno scrittore – e uomo! – del livello di Yari Selvetella. Due letture da fare in questo ordine.
Ho scritto due recensioni del capolavoro di Yari Selvetella. Un libro che sareste veramente pazzi a non leggere immediatamente. Una è dedicata esclusivamente al suo romanzo, ed è pubblicata su La poesia e lo spirito, e un'altra – per Le donne visibili – che contiene anche una parte dedicata alla letterata Giovanna De Angelis, mancata esattamente cinque anni fa oggi. Giovanna è molto ingiustamente sconosciuta ai più. In un altro Paese non sarebbe mai passata altrettanto inosservata al di fuori degli addetti ai lavori. Fa tutto parte di uno schema di cultura patriarcale in cui siamo imbibiti. Ma la sua mancanza è dolorosissima e la sua voce sarebbe stata enormemente necessaria in questo momento storico in cui il #metoo italiano è così vittima di vent'anni di berlusconismo dilagante e permeante. Sono felice che ci sia il suo romanzo da leggere, e ora anche quello di uno scrittore – e uomo! – del livello di Yari Selvetella. Due letture da fare in questo ordine.
“Le stanze dell’addio” di Yari Selvetella, un commiato dalla grande letterata Giovanna De Angelis
Una piccola premessa: nel 1631 una donna morì di parto, in India. Il suo nome era Arjumand Banu Begum e la storia ce la tramanda come una donna estremamente intelligente e di rara bellezza, piena di tenerezza verso i disagiati. Ma non sapremo niente di lei, oggi, se il suo inconsolabile sposo non avesse intrapreso la costruzione di un monumento funebre per scolpirne l’importanza e lo splendore in un marmo tanto solido e duro quanto etereo e delicato. Il suo soprannome era Mumtaz Mahal e per questo suo marito, l’imperatore Gran Moghul Shah Jahan, diede a quell’opera il nome di Taj Mahal.
L’ultima volta che lessi un romanzo di questa potenza fu una decina di anni fa, ed era “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza. Ne ho letti poi tanti altri, molto ben scritti e di grande valore. Ma è solo divorando “Le Stanze dell’addio” di Selvetella che la definizione capolavoro mi ha accompagnata in ogni millimetro della lettura, con quel senso di stupore magico che si prova quando si fa esperienza di qualcosa per la prima volta.
Questo libro ha qualcosa in più rispetto ai pur ottimi romanzi italiani che ho letto negli ultimi anni, una qualità che alza il livello letterario di un’ottava. A prescindere dal contenuto, che da solo basterebbe, ha una densità di scrittura che pochissimi romanzieri raggiungono. Mi ha fatto pensare in primis al peso specifico quasi intollerabile di “La strada” di Cormac McCarthy; e poi a uno scrittore che pure non amo, Javier Marias, per la medesima forza espressiva e condensata della parola, che lo spagnolo spende però in una narrazione fredda e fine a sé stessa. Yari Selvetella ha la potenza scrittoria dell’estrazione di una radice quadrata; ogni frase così densa e compatta, senza orpelli eppure così ricca, senza gigionerie eppure così sentimentale. Ogni capitolo come una composizione del pianista jazz Esbjörn Svensson. Dolorosa da ascoltare, ma così rara e pregiata.
 “Le stanze dell’addio” è un romanzo che parla del dolore per la morte della sua compagna, Giovanna De Angelis, ripercorrendo le fasi di quell’accadimento quasi inenarrabile come fossero dei passaggi di reparto di un ospedale, di stanza in stanza il percorso di malattia, morte e resurrezione. Affianco al memoir, necessari elementi di invenzione fittizia, perché talvolta per raccontare l’inenarrabile c’è bisogno di traslazioni simboliche. Ma le aggiunte narrative sono sempre ancorate a una verità talmente reale da essere non solo visibile, ma vivibile. Il colore dell’ospedale, il suo odore, i suoi suoni, il brusio dei corridoi, i suoi oggetti freddi e spaventevoli di persecutoria cura che ci facciamo diventare amici, complici per la nostra volontà di speranza; lo squarcio incredulo sulla crudeltà di un verdetto senza appello. E con il protagonista e il suo alter ego percorriamo la necessaria ascesa verso l’ossigeno di superficie, bracciata dopo bracciata, mentre la luce del sole si fa strada lenta ma costante; e arriviamo all’ultima stanza, quella che deve essere esfoliata, stuccata, ridipinta e aperta all’aria fresca per far posto a un nuovo amore, che nulla vuole rimpiazzare, ma che crea invece un nuovo mondo dove ridiventa possibile abitare, vivere; dopo la costruzione di questo Taj Mahal letterario.
“Le stanze dell’addio” è un romanzo che parla del dolore per la morte della sua compagna, Giovanna De Angelis, ripercorrendo le fasi di quell’accadimento quasi inenarrabile come fossero dei passaggi di reparto di un ospedale, di stanza in stanza il percorso di malattia, morte e resurrezione. Affianco al memoir, necessari elementi di invenzione fittizia, perché talvolta per raccontare l’inenarrabile c’è bisogno di traslazioni simboliche. Ma le aggiunte narrative sono sempre ancorate a una verità talmente reale da essere non solo visibile, ma vivibile. Il colore dell’ospedale, il suo odore, i suoi suoni, il brusio dei corridoi, i suoi oggetti freddi e spaventevoli di persecutoria cura che ci facciamo diventare amici, complici per la nostra volontà di speranza; lo squarcio incredulo sulla crudeltà di un verdetto senza appello. E con il protagonista e il suo alter ego percorriamo la necessaria ascesa verso l’ossigeno di superficie, bracciata dopo bracciata, mentre la luce del sole si fa strada lenta ma costante; e arriviamo all’ultima stanza, quella che deve essere esfoliata, stuccata, ridipinta e aperta all’aria fresca per far posto a un nuovo amore, che nulla vuole rimpiazzare, ma che crea invece un nuovo mondo dove ridiventa possibile abitare, vivere; dopo la costruzione di questo Taj Mahal letterario.
Ho scelto di pubblicare proprio oggi questa piccola recensione dato che ricorre il quinto anniversario della morte di Giovanna De Angelis. Mumtaz Mahal la conosciamo solo attraverso l’opera creata dal suo sposo, e questo può renderci curiosi di leggicchiarne qualche breve notizia su Wikipedia. Ma Giovanna De Angelis ci ha lasciato invece un’eredità tangibile e misurabile: in primis il romanzo “La frattura”, il suo canto del cigno scritto in tempi record durante la sua velocissima malattia − di cui avevo scritto qui. Ma vorrei che di Giovanna fossero ricordati anche gli anni di lavoro “invisibile” come editor per Einaudi Stile Libero – linea editoriale di cui si celebra profusamente Severino Cesari – per la quale ha fatto emergere i migliori e più innovativi romanzi della letteratura contemporanea italiana; e infine anche i suoi importanti lavori di critica letteraria e poesia. Un lavoro mastodontico e infaticabile di cui altri si son presi spesso il merito, cosa che mi genera molto dolore pensare. È strano perché quando vengono a mancare prematuramente persone che hanno dato così tanto con il loro talento, si finisce per avere nostalgia soprattutto delle opere che abbiamo perso. Nel caso di Giovanna invece per me è quasi il contrario: con il passare degli anni è la sua voce femminista e implacabile a mancarmi, la sua chiarezza di visione e il suo intelletto straordinario. E proprio in questo momento in cui il #metoo ha portato alla ribalta non solo l’oppressione sessuale del patriarcato sulla donna, ma anche tutto lo spazio che la predominanza maschile sottrae al lavoro, al talento e alla dedizione di troppe figure femminili che vengono fagocitate dai propri padroni (che siano i capi al lavoro, i registi sul set, o i propri mariti), ho una nostalgia dolorosissima di Giovanna De Angelis. Per questo ringrazio Yari Selvetella, che con questo romanzo ha edificato un monumento che la farà ricordare per sempre.
Foto di Mikael Moiner
Le donne visibili
La poesia e lo spirito
